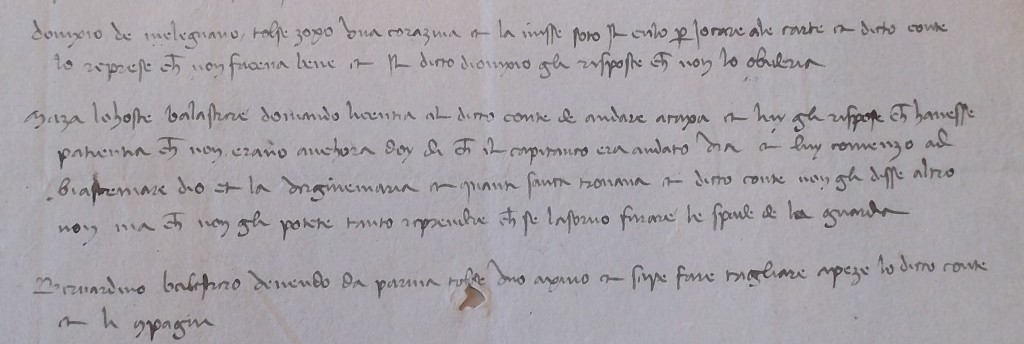Articolo di MARCO VIGNOLA
Pubblicato il 19.06.2024; tutti i diritti riservati.
INQUADRAMENTO TIPOLOGICO GENERALE
La consuetudine di sospendere alla cintura piccoli coltelli racchiusi in foderi di pelle, solitamente stampigliati o incisi, risulta ampiamente attestata in tutta l’iconografia bassomedievale e ben oltre i limiti del XV secolo.
Le dimensioni delle loro lame non sono in genere condizione sufficiente per ascriverli alla categoria delle “armi”, ma piuttosto tra gli utensili di uso comune. Si trattava, in estrema sintesi, di oggetti dalla funzione squisitamente pratica e civile, sottolineata da un tagliente in genere troppo ridotto per un impiego in campo bellico.


Approcciandosi ad una descrizione tipologica delle lame di coltello, come succede per molti attrezzi di impiego quotidiano, bisogna tuttavia premettere il forte conservatorismo delle forme funzionali, che si possono mantenere quasi intatte per secoli e secoli, complicando o vanificando qualsiasi sforzo d’inquadramento troppo stretto.
A livello descrittivo, tuttavia, è comunque possibile individuare almeno tre grandi “famiglie”, tutte attestabili nel nostro periodo di riferimento, sebbene con diverso profilo di rarità: serramanico, a codolo stretto, a codolo largo.
La prima di queste era caratterizzata da una lama (solitamente di dimensioni contenute) terminante in una linguetta collocata vicino al perno ove ruotava dentro al manico, a sua volta realizzato in materiale organico o talvolta in metallo. Tale linguetta, secondo un un impiego ancora attuale nei rasoi, aveva la funzione di facilitare l’estrazione del tagliente e mantenerlo in posizione, senza l’ausilio di molle o meccanismi d’arresto.
Ritrovamenti di coltelli a serramanico di ogni genere sono relativamente sporadici in contesti bassomedievali, in rapporto a quelli a lama fissa. Su un campione di ben 310 reperti individuati in scavi londinesi, per esempio, solo due sono a serramanico; situazione analoga a Rougiers, nel sud della Francia, dove questa tipologia risultava minoritaria. Restando in ambito italiano, alcuni esemplari figurano in repertori friulani (come Attimis e il Castello della Motta) e in altri contesti quali Castel Pietra a Gavorrano (GR) e Tremona, nel Canton Ticino.
Per quanto poco comuni, dunque, i serramanico dovevano essere sufficientemente diffusi e declinati in una rosa di forme difficilmente inquadrabili in una precisa area geografica o in un arco di tempo troppo ristretto, trattandosi d’una tipologia già documentata almeno dall’Alto Medioevo.

La seconda famiglia, certamente più comune della precedente, è quindi costituita dai tipi “a codolo stretto”, ove la lama terminava in un sottile prolungamento a “chiodo” inserito dentro a un manico di vario materiale e qui ribattuto. Dall’età romana tale forma risulta pressoché esclusiva in contesti nazionali insieme ai serramanico almeno fino al XIII secolo, quando ad essa cominciarono ad affiancarsi i tipi “a codolo largo”, come dimostrato in maniera non equivoca dagli scavi di Castelfranco Emilia (MO).
Analogamente a moltissimi coltelli odierni, due guanciole erano qui fissate alla superficie spianata del codolo tramite una serie di ribattini passanti, col risultato di un insieme decisamente più robusto rispetto alle tipologie a codolo stretto, sempre più rare col progredire del Trecento e ormai residuali nella seconda metà del Quattrocento.

L’uso di trattenere le guanciole del manico tramite rivetti è in ogni caso corroborato nel Duecento anche per via iconografica: nelle scene di battaglia affrescate sulle pareti del Palazzo Comunale di San Gimignano, infatti, compaiono già alcune basilarde dotate di un manico a guanciole rivettate tra il 1288 ed il 1292, segnando un prezioso termine iconografico ante quem per questa soluzione tecnica.
Anche nel contesto ticinese di Tremona, manufatti di questo genere si attestano già in ambiti di XIII secolo, rafforzando l’idea di una transizione tipologica molto graduale a partire dal secondo Duecento.

Tornando allo specifico della seconda metà del Quattrocento, i coltelli appartenenti a quest’ultima famiglia risultano decisamente i più documentati a livello iconografico ed archeologico, con una declinazione di varianti strepitosamente ampia.
A livello strutturale si osservano tuttavia alcune costanti che attraversano tutto il nostro periodo di riferimento.
In prima battuta, il codolo sul dorso viene quasi sempre a rastremarsi verso l’estremità del manico: espediente utile a ridurne il peso, spostando il bilanciamento della lama verso la punta. Un baricentro più avanzato, infatti, rendeva meno soggetto al ribaltamento un coltello appeso alla cintura, minimizzando (insieme a foderi conformati per accogliere la parte del manico più prossima alla lama) il rischio di smarrimento accidentale.
Un’altra caratteristica tecnica pressochè invariata nei coltelli della nostra epoca si localizza nel punto di passaggio tra guanciole e lama, il quale poteva essere lasciato franco da decorazioni oppure arricchito da elementi in lega di rame diversamente sagomati, ma comunque sempre rivettati al corpo del coltello.
In taluni casi, la transizione poteva essere segnalata da una lamina metallica (quasi sempre ottone, più di rado argento) che sovente veniva interposta tra guanciole e codolo, qui semplicemente ripiegata verso l’alto a rifasciare l’estremità delle guanciole stesse.

Col volgere del Quattrocento e il principio del Cinquecento, tuttavia, gli antichi coltellinai iniziarono a realizzare un ringrosso alla base del codolo, finendo per sostituire le vecchie applicazioni con un nodo (spesso modanato) forgiato in un sol pezzo nel corpo del coltello: nasceva così una forma “moderna” che nel Cinquecento avrebbe rapidamente conosciuto una vasta fortuna, soppiantando le precedenti.
La varietà tipologica estrema di queste soluzioni permise una vastissima gamma di forme e decori, legati a specifiche funzioni, aree geografiche, prezzo e gusti individuali: una galassia che proveremo ad esplorare (anche solo in minima parte) nel prossimo contributo legato al mondo della coltelleria.

Bibliografia sintetica
BELLI M. 2002, I reperti metallici provenienti dallo scavo di Castel di Pietra: studio preliminare dei contesti e presentazione della tipologia morfologica, inC. Citter(a cura di), Castel di Pietra (Gavorrano – GR): relazione preliminare della campagna 2001 e revisione dei dati precedenti, “Archeologia Medievale”, XXIX, Firenze, pp. 165-167.
COWGILL J. – DE NEERGAARD M. – GRIFFITHS N. 1987, Medieval finds from excavations in London: 1. Knives and scabbards, Woodbridge.
DEMIANS D’ARCHIMBAUD G. 1980, Le fouilles de Rougiers (Var). Contribution à l’archéologie de l’habitat rural médiéval en pays méditerranéens, Paris.
DU HEAUME G. 2020, The Queenhithe Collection, “Journal of the Antique Metalware Society“, 25, Suffolk.
LIBRENTI M. – ZANARINI M. 1998, Archeologia e storia di un Borgo Nuovo bolognese: Castelfranco Emilia (MO), in Archeologia in Emilia Occidentale. Ricerche e studi, a cura di S. Gelichi, Mantova, pp. 79-113.
MARTINELLI A. 2008, I reperti metallici, in Tremona Castello. Dal V millennio a.C. al XIII sec. d.C., a cura di A. Martinelli, Firenze, pp. 272-311.
PIUZZI F. 2003 (a cura di), Lo scavo del Castello della Motta (Povoletto), Firenze.
VIGNOLA M. 2003, I reperti metallici del Castello Superiore di Attimis, “Quaderni Friulani di Archeologia”, XIII, Udine, pp. 63-81.