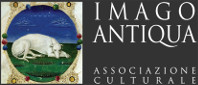Articolo di MARCO VIGNOLA
Pubblicato il 17.07.2025; tutti i diritti riservati.
Uno degli interrogativi più “spinosi” relativi alle difese delle fanterie italiane nel pieno Quattrocento è sempre stato l’impiego o meno dei petti da fante cosiddetti “alla tedesca”.
Se la loro produzione negli ateliers peninsulari è assolutamente “certificata” dalla munizione conservata a Castel Coira (marchiata con segni bresciani non equivoci), a livello iconografico tali protezioni non sembrano presentarsi almeno fino agli anni ‘90 del secolo, quando Vittore Carpaccio li ritrae nelle sue Storie di Sant’Orsola.
L’impiego dei petti “globoidi” tipici del secondo Trecento (ben testimoniati, per esempio, dall’altare argenteo di San Jacopo a Pistoia) sembra infatti interrompersi, mentre incontestabile risultava il favore del quale godevano le “brigantine”.

Il testo di un piccolo quaterneto milanese, condizionato nella busta miscellanea “Autografi, 227” dell’Archivio di Stato di Milano e recentemente trascritto integralmente in un mio contributo reperibile su Academia, può offrire tuttavia qualche spunto interessante su questo capitolo molto specifico dell’oplologia.
Compilato nel 1451, la sua stesura sembrerebbe il prodotto di una sola missione compiuta da Giovanni Orombelli, “collaterale” di Francesco Sforza, visitando le rocche sparse nei territori sud-occidentali del ducato, a guardia degli strategici passi appenninici fin verso Parma, Piacenza e quindi Milano.
Tra i molti inventari qui stilati, uno relativo alla fortezza dei San Colombano al Lambro (citato integralmente in appendice) menziona esplicitamente la presenza di ben 10 “pecti de azale novi”.
Ferme restando tutte le possibili incertezze lessicali che potrebbero inficiare la corretta lettura degli antichi inventari, il termine “pecto de azale” (= petto di acciaio) lascia ben poco spazio a dubbi, così come l’aggettivo “novi”, logicamente indicante prodotti “nuovi”.
Trattandosi di pezzi di fresca manifattura, inoltre, possiamo con buona certezza escludere che si trattasse di elementi residuali, come per esempio il “pectum ferreum” citato nella periferica rocca di Ranzo, in provincia di Imperia, molto probabilmente un esemplare ormai vetusto della più vecchia tipologia globoide (1424; Archivio di Stato di Genova, Antico Comune 338, c. XXVII v.).
Possiamo dunque asserire con qualche certezza che intorno alla metà del XV secolo almeno una fortificazione in suolo italiano vantasse una munizione abbastanza numerosa di petti da fante, molto probabilmente di fabbrica milanese, dato che le turbolenze belliche antecedenti la Pace di Lodi certamente non favorivano l’importazione di materiali strategici come le armi.

A livello storico ricostruttivo, è in ogni caso utile ricordare la fortissima prevalenza di armamenti corazzati tanto negli inventari quanto nell’iconografia, sconsigliando dunque indebite generalizzazioni in merito ai petti da fante.
E’ tuttavia probabile che a difesa dei parapetti di alcune fortificazioni queste difese venissero salutate con favore, in quanto più comode delle brigantine e tutto sommato equivalenti a livello protettivo, visto che i difensori in questo caso non dovevano presentare la schiena agli assalitori, a differenza delle fanterie campali molto più mobili ed esposte anche sulle terga.
Archivio di Stato di Milano, Autografi, 227, c. 2v.
Sanctocolumbano
In esso castello de Sanctocolumbano gli sono le infrascripte a presso de magistro Ioseph ibidem castellano et cetera:
prima balestre IIII° a bancho cum banchi II
item balestre IIII° a molinelo senza molineli
item Iᵃ altra balestra a molinelo rota
item balestre VIII a cirela et a manete sine crochi et cireli et Iᵃ stambuchina, quale sono inutille
item coraz(e) VII coperte cum suoy speraroli
item coraz(e) V [1] scoperte sine speraroli
item pecti X de azale novi
item tarchoni VIIII° et sgiopeti VIIII°
item sgiopeti II roti
item spingarda Iᵃ de metalo
item Iᵃ altra de ferro cum suo cepo
item libre CCL de piombo cum certe balote
item bombardele V pizole da mano
item capse XIIII° de veretoni a bancho et a busola
item barili VI½ de polvere a bombarda
item barile I a schiopeti
item Iᵃ corda grossa e longa
item lumerii II et due lucerne
item stopini XXV et palli II de ferro
item cadene II a ponte levatorio cum certis fornimentis
item gavete XIIII° de fillo a balestre
item stari LXXVII furmenti
item campana una Iᵃ et I° curlo [2]
item lectere X tra grande e pizole
item banche IIII° grande e pizole
item archoni II° et discho uno
item modii V farine
item vaseli VIII a vino de brente XLIII et pleni
item capsono I° a farina et Iᵃ buratora
item molandino I fornito da macinare
item vaseli X de brente C in li quali sono brente LX vini albi et vermili
item vaseli a vino quali sono del magnifico mesere Cicho.
[1] “segue “s” e altra lettera abbozzata depennate
[2] Così nel testo
*** CLICCA QUI per leggere l’articolo completo su Academia.edu ***